La mia vita, parte sesta
Il sogno
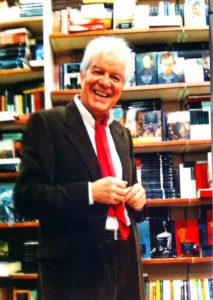 A Melbourne, all’inizio degli anni Settanta, ho cominciato a dare lezioni di francese e d’italiano a piccoli gruppi di studenti delle scuole private – International School of languages, Holmes language school, Berlitz language school. Non avevo, come avrei voluto avere, una conoscenza solida e profonda di queste lingue, comunque, quella che avevo bastava per quello che dovevo insegnare. Inoltre avevo un’ottima esperienza personale con le lingue e questo mi rendeva il mestiere più facile.
A Melbourne, all’inizio degli anni Settanta, ho cominciato a dare lezioni di francese e d’italiano a piccoli gruppi di studenti delle scuole private – International School of languages, Holmes language school, Berlitz language school. Non avevo, come avrei voluto avere, una conoscenza solida e profonda di queste lingue, comunque, quella che avevo bastava per quello che dovevo insegnare. Inoltre avevo un’ottima esperienza personale con le lingue e questo mi rendeva il mestiere più facile.
Qualche anno dopo, con l’aiuto economico d’un amico italo-australiano e restando fedele a un mio principio: se gli altri ci riescono, perché non dovrei riuscirci anch’io?, ho aperto una scuola di lingue nel centro della città: European School of Languages.
Il successo è stato, a dir poco, strabiliante. Nel giro di qualche anno, alla European School of Languages insegnavano part-time circa venticinque professori di madre lingua e tutte le aule disponibili erano impegnate al massimo. Fantastico!
È stato allora, proprio in quel periodo favoloso e straordinario della mia vita che, mentre scrivevo qualcosa sulla lavagna, tutto d’un colpo sono finito sul pavimento privo di sensi. Il panico e lo sgomento dei miei studenti è stato totale. Alcuni di loro, una volta che si sono ripresi dallo shock, mi portarono all’ospedale di South Melbourne. Non so cosa mi abbiano fatto qui, so solo che mi sono ripreso dopo alcune ore. Cosa mi era successo? Non si sapeva. Si sapeva solo che ero svenuto mentre insegnavo. Mi hanno chiesto se era stata quella la prima volta. No, c’era stato un precedente. La stessa e medesima cosa mi era successa una sera in Francia tanti anni prima. Mi trovavo in una pensione di montagna dov’ero andato in una trasferta di lavoro. Non c’erano ospedali né dottori lì. I proprietari del locale mi avevano portato in una cameretta, messo su una specie di branda e poi mi avevano lasciato lì fino a quando non mi fossi ripreso o fossi morto.
La mia dottoressa, Joan Fraser, un’amica e una poetessa, disse che dovevo sottopormi a una serie di esami per capire cos’era successo. Così ho fatto. Per prima cosa sono andato in una clinica in St. Kilda Road, penso che si chiamasse Shepherds Clinic, dove, in una sola giornata, mi sottoposero a parecchi test. Nonostante ciò, non riuscirono a diagnosticare nulla di particolare. C’era però qualcosa di strano nel sangue. Dovevano farmi altre analisi. E così, per una buona settimana, andai avanti e indietro da uno studio medico all’altro. Alla fine erano riusciti a capire che avevo la talassemia ossia il morbo di Cooley. Non si sapeva però se era la talassemia maggiore o minore. Con la prima, mi avevano detto, mi sarebbe rimasto poco da vivere. Stupendo!
Alcuni giorni dopo, mentre mi recavo alla clinica in macchina, mi ero fermato a Toorak, uno dei sobborghi chic di Melbourne, ero entrato in un negozio di specialità europee e avevo chiesto alla commessa un intero camembert, così com’era esposto in vetrina, e una bottiglia di cote du Rhone stappata. Dopo aver pagato, ero uscito dal negozio mangiando formaggio e bevendo vino direttamente dalla bottiglia. Prima di arrivare all’auto, ho buttato in una pattumiera quel che rimaneva del camembert e del vino, poi sono salito, ho acceso il motore, inserito nel mangianastri una cassetta di Theodorakis al massimo volume e sono partito come un razzo pensando che stavo per morire.
L’idea che i miei giorni avrebbero potuto accorciarsi drammaticamente, mi dava una sensazione di estraneità, ero continuamente preda di cupe riflessioni, esageravo ogni cosa. Mi sentivo un alieno tra gli umani, mi pareva di non appartenere più a loro, al mondo, a nessuno, neppure a me stesso. I miei simili mi erano diventati estranei e la terra su cui camminavo non mi apparteneva più. Vedevo tutto nero, anche se tutto nero non era. Durante la notte dormivo pochissimo. Il pensiero della morte mi dominava, mi isolava come si isolano certi animali quando avvertono la presenza dell’inevitabile.
In quel periodo stavo attraversando una bella stagione della mia vita, un vero e proprio successo economico, culturale e sentimentale: gestivo una scuola di lingue dinamica e redditizia che io stesso avevo fondato, European School of Languages. Mi piaceva il mio lavoro, avevo ottimi rapporti con gli insegnanti e gli studenti, avevo conoscenze, ero stimato, amato e stavo per sposarmi, almeno l’intenzione era questa con la mia ragazza, Elizabeth.
Non riuscivo a capire, a dare una spiegazione, un senso a tutto quello che mi stava succedendo e, più ci riflettevo, più tutta la cosa mi diventava indigesta. Ero sconvolto. L’idea di quello che avrebbe potuto succedermi mi scombussolava e mi faceva fare cose assurde. Era l’ironia della sorte, era la beffa, l’imprevedibile, il cinismo. Avevo lavorato così tanto per raggiungere quella piccola soddisfazione, e ora? E non solo. Volevo fare ancora tante altre cose. No, non si poteva programmare nulla, proprio nulla, solo il presente contava e il mio era pieno d’incogniti. Una volta ancora, io non ero più io.
Alcune settimane dopo il mio incidente in classe, mi richiamò la dottoressa Fraser dicendo che aveva ricevuto il referto dei miei esami e che sarebbe venuta a portarmelo.
Quando le aprii la porta, il mio cuore batteva freneticamente. Mi comunicò che la mia talassemia non era quella maggiore. Solo se mi fossi sposato con una donna, anche lei portatrice di talassemia, avremmo dovuto fare attenzione, perché su quattro figli, uno sarebbe nato con questa anomalia del sangue. Udita la notizia, con un gesto incontrollabile, presi la dottoressa tra le braccia, la sollevai e mi misi a girare intorno al soggiorno come se stessi ballando un rapidissimo valzer, mentre lei strillava che la mettessi giù. Quando lo feci, i miei occhi erano pieni di lacrime.
A volte, quando ripenso a questo episodio della mia vita, lo liquido con qualche parola, ma ci sono volte che mi viene voglia di scrivere un intero libro. In ogni modo, da quel momento in poi, da quando la dottoressa Fraser mi diede la bella notizia, le cose ritornarono al loro posto, con questa differenza: era scoppiata dentro di me una voglia selvaggia di vivere, vivere, vivere a più non posso, perché di doman non v’è certezza.
Ho ripreso di nuovo la scuola in mano. L’ho gestita per diversi anni. Lavoro piacevolissimo, anche se impegnativo e delicato. Impegnativo perché prendeva tutto il mio tempo; delicato perché, nonostante la cultura dominante fosse quella australiana, dovevo anche fare i conti con la provenienza di ognuno dei miei insegnanti.
Solo con uno di loro ho avuto dei problemi. Era un professore doc di giapponese. Tutte le volte che assumevo un nuovo insegnante, gli spiegavo come funzionava la European School of Languages, gli dicevo quello che pagavano gli studenti sia per le lezioni di gruppo che per quelle private. Era d’accordo su tutto, il prof giapponese. Bene. Gli avevo, poco dopo, organizzato un gruppetto di studenti formato da tre donne e due uomini. La sera della prima lezione, mentre gli studenti erano in classe, era venuto da me dicendomi che non poteva insegnare per i soldi pattuiti. Voleva di più.
Come?
Un vero professore non si disturba per ciò che lei paga.
Le avevo spiegato come stavano le cose.
Lo so, ma non sono più d’accordo.
Mi segua, dissi.
L’ho portato dai suoi studenti e ho detto loro che il professore non era più soddisfatto con quello che lo pagavo. Ho detto che gli davo il 70% di quello che avevano pagato e che lui, in un primo tempo era d’accordo, ora aveva cambiato idea, ora, per pagarlo, non bastavano i soldi di tutti loro messi insieme. Per di più, aveva aspettato per dirmelo all’ultimo momento. Il fatto che la European School of Languages pagava l’affitto per il locale, per la pubblicità che faceva per i corsi, aveva a carico una segretaria e per tutte le altre spese, lui non voleva saperne, voleva solo più soldi. Era un professore e voleva essere pagato come un professore. Una volta detto questo, mi sono rivolto a lui dicendogli che poteva considerarsi libero e che la European School of Languages non ne aveva più bisogno, mentre agli studenti ho detto, dopo essermi scusato per l’accaduto, che nel caso non volessero attendere che gli trovassi un altro professore, possibilmente non doc questa volta (risero), potevano andare dalla segretaria e farsi rimborsare i soldi che avevano pagato per il corso. Non l’hanno fatto. Hanno aspettato e quando gli ho trovato il nuovo professore, hanno portato con loro altri cinque studenti, conoscenti e amici, così erano dieci!
La European School of Languages era frequentata non solo dai soliti burocrati, hostess, infermiere, dottori, lavoratori che avevano bisogno di conoscere la lingua d’un determinato paese per ragioni di lavoro, business, ecc., ma era frequentata anche da gente ricca e importante. Usualmente queste persone prendevano lezioni private. È da alcune di queste persone che ora vorrei dire due parole.
Una di queste era la vedova d’un generale dell’esercito. Era morto da poco e lei aveva scritto, subito dopo il suo decesso, un libro su di lui. Aveva cercato di pubblicarlo, ma non era stata fortunata con l’editoria australiana. Allora voleva, col mio aiuto, tradurlo in francese. Le ho detto che non ero all’altezza del compito, ma lei insistette dicendo che bastava che io l’aiutassi solo un po’, perché lei il francese lo conosceva bene avendolo studiato all’università. Ho fatto tutto quello che ho potuto, e quello che ho potuto per me è stato molto. La cosa ha avuto una svolta inaspettata quando lei ha iniziato ha ritoccare il suo dattiloscritto, a fare delle correzioni, a non essere più contenta di quello che aveva scritto. Diceva che non l’avrebbe creduta nessuno. Era quello che pensavo anch’io. In ogni caso, una mattina, dopo l’ennesimo ritocco, scattò in piedi dicendo in inglese: “I’m fed up with all this shit!” E dopo aver fatto a pezzi lì per lì il dattiloscritto che portava sempre con sé, dopo essersi scusata con me per il casino che aveva fatto e per quello suo scoppio d’ira, era uscita dalla classe furiosa e rossa in faccia come i semi d’un melograno. Non la rividi più. Dico solo questo riguardo al libro che voleva pubblicare: l’esercito, e non importa a quale paese appartenesse, ci ha guadagnato molto, grazie alla fine che aveva fatto quel dattiloscritto.
La signora T era un’arcimiliardaria. Era stata un’artista, un soprano d’opera, una persona importante nell’ambito del palcoscenico locale e internazionale (aveva avuto le sue tournée in giro per il mondo). Ora però, alla sua età, non l’era più, ora si doveva accontentare di ricevere a casa le nuove celebrità di questo melodramma vocale e musicale. Me ne parlava tanto di loro. Anzi, era di queste celebrità che alla signora T, e non solo di quelle australiane, piaceva parlare nella sua ora e mezzo di lezione: 45 minuti in francese e 45 minuti in italiano. Amava tutt’e due queste lingue e le parlava con stile e gusto.
La signora T aveva una figlia. Questa era sposata con un ambasciatore scandinavo. A ogni suo compleanno, con l’aiuto d’un fedele maggiordomo, le faceva trovare sotto il cuscino una busta col regalo di compleanno dentro. Questo poteva essere una villa sulla Costa Azzurra, un giro del mondo in una nave di crociera di lusso, una Ferrari, ecc. La stranezza di questa sua relazione con la figlia, era che lei, la signora T, nonostante le facesse questi esorbitanti regali, in realtà odiava la figlia perché “era una spendacciona e una buona a nulla” diceva con stizza. Non voleva vederla neppure il giorno del suo compleanno!
Mi aveva fatto conoscere suo marito, un oculista. I suoi libri facevano parte del curriculum di parecchi atenei di medicina in Australia. La cosa che più mi faceva ridere e riflettere di questa coppia, era quando lei aggrediva il marito dicendogli che non voleva più andare in macchina con lui, perché, quando la sera ritornavano a casa dalle loro serate di beneficenza, al dottore piaceva passare i semafori, verdi, gialli o rossi che fossero, a grande velocità e con gli occhi chiusi con la sua Rolls Royce, e questo mentre lei gli urlava a più non posso che si fermasse. Non l’aveva mai fatto. Solo una volta non si era scontrato con un’altra macchina per poco, ma prima o poi, diceva la signora T, questo sarebbe successo.
Le classi della European School of Languages sono state onorate anche d’una contessa. Che lo fosse stata veramente o no, non ho mai cercato di appurarlo. Non m’interessava. Comunque, questa contessa, e devo dire che era molto bella ed elegante, studiava il tedesco con la professoressa di tedesco, la signora Magda. Io, dopo che lei aveva fatto l’iscrizione e iniziato il suo corso, la vedovo solo qualche volta alla macchinetta del caffè e quando arrivava a scuola. La contessa, e questo era curioso, per ben tre volte mi aveva messo nella tasca della giacca, senza farsi notare dagli altri e neppure dalla segretaria, una piccola busta con dentro un bigliettino e le chiavi del suo appartamento invitandomi ad andare a trovarla in orari strampalati. Non l’ho mai fatto.
Ho avuto anche come studente un chirurgo di estetica del volto. Paul B era sposato con una ragazza italiana, Tiziana, simpaticissima. L’ha portato lei stessa alla European School of Languages dopo avere letto un annuncio che avevo fatto sul giornale The Age. Voleva che imparassi l’italiano e lui era ben contento di farlo, prima per fare contenta Tiziana e secondo perché lo studio dell’italiano lo distraeva un po’ dai suoi affollati impegni. Siamo diventati amici in brevissimo tempo. Quando mi avevano diagnostico il morbo di Cooley, Paul, che non conosceva bene questo tipo di malattia, aveva trascorso tutta la notte a leggere articoli e libri per saperne di più. È stato lui per primo a dirmi quello che poi mi avevano confermato i dottori della Shepherds Clinic e la stessa dottoressa Fraser.
A Paul piaceva la scienza, la natura, gli animali. Diceva che a 45 anni avrebbe venduto la sua clinica e si sarebbe comprato un podere nel Victoria riempiendolo di animali e poi si sarebbe dedicato a loro e a costruire una particolare tosatrice di pecore (ho saputo, dopo, che aveva mantenuto la parola: quando aveva compiuto 45 anni, aveva venduto la clinica e si era comprato il suo tanto amato podere; ho saputo anche che anni dopo aveva presentato, in una mostra a Adelaide, la sua tosatrice di pecore, poi non ho più avuto notizie di lui). Con Paul, a volte, il sabato sera, dopo cena, lo trascorrevamo chiacchierando su tanti argomenti, mentre Tiziana ad un certo punto andava a letto, per poi, ogni tanto, arrivare insonnolita e in pigiama nel salone in cui eravamo dicendo: “Ma siete ancora lì?”
Cos’altro dire? Solo questo. La European School of Languages è stata per me una palestra sociale, culturale, intellettuale, umana, un luogo ricco di personalità, di lingue e di tradizioni internazionali. Ho imparato moltissimo, tanto dagli insegnanti quanto dagli studenti. Devo molto a quest’esperienza, io, a questo sogno che il posto dov’ero mi ha permesso di realizzare. Grazie Melbourne! Grazie Australia!
Verso la fine degli anni Settanta, non volendo più continuare questo tipo di lavoro: bello sì, interessante sì, redditizio sì, tutto quello che si vuole, ma che si prendeva ogni briciola del mio tempo e della mia vita rendendomi suo schiavo. E non solo. Mi stava trasformando in uno spilorcio: i soldi richiedono altri soldi. Più d’una volta avevo pensato di aprire altre scuole di lingue nelle altre principali città australiane. Non l’ho mai fatto. Decisi invece di vendere la European School of Languages e di lasciare l’Australia.
