La mia vita *
L’io chiuso
11 febbraio ‘42
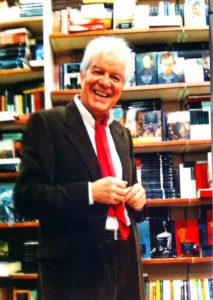 Accenno solo, a questa mia breve autobiografia, che io sono uno scrittore che non può fare a meno di scrivere ciò che scrive, proprio come le donne, una volta incinte, non possono fare a meno di partorire il bimbo che portano in grembo. Anche per me, come per le madri, è un fenomeno genetico, non posso tenere dentro di me quello che è figlio, non della mia fantasia, ma della mia esperienza, quindi della mia vita. È di questo che vi parlerò in ciò che segue.
Accenno solo, a questa mia breve autobiografia, che io sono uno scrittore che non può fare a meno di scrivere ciò che scrive, proprio come le donne, una volta incinte, non possono fare a meno di partorire il bimbo che portano in grembo. Anche per me, come per le madri, è un fenomeno genetico, non posso tenere dentro di me quello che è figlio, non della mia fantasia, ma della mia esperienza, quindi della mia vita. È di questo che vi parlerò in ciò che segue.
Se qualcuno dei siti specializzati non desidera riceverla, me lo dica. Non ci sarà nessun problema. Capisco e ringrazio per avermelo detto.
Il caso
Sono nato nel 1942 in un vecchio rudere di famiglia che chiamavamo casa, in un paesino di montagna, in Calabria. Era febbraio, un mercoledì nel tardo pomeriggio. Lontano, sul mare, raccontava poi la mamma, mentre io venivo al mondo, si sentivano le cannonate lanciate da una nave da guerra contro gli aeroplani che cercavano di affondarla. Quest’idea, più tardi, mi avrebbe fatto riflettere non poco: da una parte nasceva la vita e dall’altra la si distruggeva; da una parte la gioia, la felicità, dall’altra il terrore e la morte.
A due anni, nel ’44, uno squilibrato che abitava vicino a noi, senza una ragione apparente, uccise mio padre con un colpo di ascia in testa mentre lavorava nei campi.
Eravamo quattro figli, due maschi e due femmine. Mio fratello Vincenzo, di vent’anni più vecchio di me, in quel periodo era prigioniero in Russia.
Era l’autunno del ’46, la guerra era appena finita, ma il suo macabro odore era ancora nell’aria, quando la mamma divise in tre parti una mela, l’ultima sfuggita ai predoni e rimasta sull’albero, e ce la diede. Lei non ne mangiò. Per tre giorni quella mela fu il nostro unico cibo.
In quei tempi avevo fame, sempre fame. Il mattino mi alzavo affamato e la sera andavo a letto affamato. Si mangiava quando c’era cibo e ce n’era raramente. Anche i campi erano devastati e privi d’un qualsiasi nutrimento. La fame dominava le nostre vite. Una volta abbiamo ucciso un ratto: un vero festino!
Soffrivo perennemente di pellagra, di mancanza di vitamine, d’una debolezza cronica; mi ammalavo facilmente, avevo quasi sempre l’orticaria alle mani e un prurito costante e irritante mi spingeva a grattarmi continuamente. Ero pelle e ossa nonostante fossi nato paffutello.
La mamma si è sposata due volte, la prima secondo le regole, la seconda secondo le usanze locali. Io e le mie due sorelle siamo nati dal suo secondo compagno, di cognome Ferreri. Di quest’ultimo, dopo che il folle l’aveva ucciso, avevamo ereditato del denaro con il quale abbiamo comprato un pezzo di terra che coltivavamo noi stessi, insieme a un altro pezzo che avevamo a mezzadria. Erano questi due terreni la fonte del nostro sostentamento, penoso e difficile, ma comunque ci tenevano in vita.
Una sera la mamma fu vittima d’un attacco d’asma. Non riusciva a respirare. Rantolava. Le mancava l’aria, pareva stesse per morire. Boccheggiava, faceva dei versi terribili. Ero terrorizzato nel vederla in quello stato. Scoppiai a piangere e nella mia disperazione mi aggrappavo a lei rendendo la sua crisi ancora più difficile. Le mie sorelle mi strapparono decise da lei e mi portarono via. Più tardi, quando la rividi, stava meglio. Fu l’unica volta in cui vidi la mamma star male.
Era l’inizio del ’48. Avevo sei anni. Fuori faceva freddo, si sentivano raffiche di vento e pioggia mista a grandine sul tetto. Io e lo zio Carlo eravamo seduti in silenzio vicino al focolare. A un certo punto, lo zio mi assalì dicendo:
“Lo sai, eh, lo sai che tu sei più ricco di me?”
“Non è vero, zio,” ho risposto pronto come se quella domanda me la fossi aspettata, “sei tu il più ricco.”
“Non intendo ricchezza materiale, soldi case terreni animali,” ha risposto lui tetro e con disgusto, “intendo ricchezza in età, in giovinezza, vita. Tu sei un ragazzino, io quasi un vecchio; tu hai il mondo davanti a te, io la fossa. Capisci?”
“No,” ho risposto.
“Peggio per te!” ha fatto lui.
“La zia,” (sua moglie), ho detto io allora, “dice che dopo la morte andremo tutti in paradiso e lì vivremo per sempre.”
“Quindi capisci!,” ha quasi urlato lui con stizza. “E comunque non parlarmi delle sciocchezze che dice tua zia.”
“Sciocchezze?,” ho fatto io. Non l’avevo mai sentito parlare in quel modo della zia.
“Sì, sciocchezze!”
“Spiegami.”
“Non so spiegartelo.”
“Continuo a non capire.”
“Un giorno forse capirai. E ora stai zitto!” ha troncato lui, mettendosi, nervoso e arrabbiato, ad attizzare il fuoco.
L’ho guardato, poi ho chinato la testa e non ho detto altro.
Lui neppure.
Nonostante la mia giovane età, questo episodio con lo zio Carlo mi scosse profondamente, suscitando in me domande che fino ad allora ignoravo: domande sulla vita, sul tempo, sulla morte, sull’esistenza di Dio. Volevo risposte a questa mia improvvisa inquietudine interiore, ma non ne trovavo. Neppure lui, lo zio, anche quand’era più avvicinabile e meno scontroso, era in grado di rispondere alle mie insistenti e sentite domande, e intuivo, fortemente intuivo, che avrebbe tanto voluto sapermi rispondere.
Lo stesso anno, dopo alcuni mesi che la scuola era iniziata, ho incominciato ad andarci anch’io. Non senza difficoltà. Primo, perché la mamma non voleva mandarmi, secondo perché doveva indebitarsi col calzolaio per comprarmi un paio di scarpe (i miei piedi non le avevano mai conosciute prima d’allora le scarpe, e a scuola non si poteva andare senza), e terzo perché la scuola si trovava in un paese lontano da casa. In ogni modo, dovevo andarci, era obbligatorio e, alla fine, la signora ha dovuto mollare la presa.
A scuola ho scoperto che parlavo in dialetto, una lingua, diceva il maestro, locale, volgare, rozza, dei cafoni. E non solo. Ho scoperto anche quanto era brutto non avere un padre; quant’era brutto sentire dicerie su mia madre e sulle mie sorelle; quant’era brutto sentirsi impotente di fronte alla brutalità gratuita e insolente di certi ragazzi.
Un giorno, mentre la mamma e le sorelle erano nei campi, io ero rimasto a casa. Ero nell’orto con i miei cardellini in gabbia (non ricordo chi aveva iniziato a farmi amare questi uccellini, ma erano la mia passione di allora), appesi al ramo d’un fico, quando mi sono trovato davanti un giovane. Non lo conoscevo, mai visto prima. Non aveva un aspetto simpatico. Disse senza mezzi termini che mi avrebbe portato via gli uccelli e altra roba.
“Cosa?” feci io.
“Hai sentito bene,” rispose lui.
“Neppure per sogno.”
“Mi prendo lo stesso ciò che voglio.”
“Provaci!”
Nel giro di qualche istante siamo arrivati subito al dunque. Ci acchiappammo. Lottammo. Lui era più grosso e più grande di me e picchiava sul serio. Sentivo che non ce l’avrei fatta per molto, ma non mollavo. Riuscì, dopo un po’, a buttarmi per terra e subito dopo si era messo sopra di me a cavalcioni immobilizzandomi. Mi dibattevo, ma non c’era via di liberarmi. “Ti potrei ammazzare, disse, e prendermi quello che voglio.”
“Fallo e vedrai!”
Come risposta le sue gambe mi strinsero come molle e con le mani sollevò la mia testa e la sbatté più volte per terra facendomi molto male. Poi smise, mi guardò schifato. Rimase lì sopra di me mentre io continuavo a dibattermi, forse rifletteva sul da fare. Disse sprezzante:
“Sei un cafone, non vali niente, niente di niente, e non c’è nulla in questo pidocchioso posto che possa interessarmi” e, mollando la presa e senza fiatare altro, si alzò e se ne andò lasciandomi lì per terra in stato di shock.
E uno shock è stata quell’esperienza. Da un momento all’altro, senza un perché, mi ero visto, di fronte a casa mia, immobilizzato con violenza, privato della mia libertà e riempito di botte da un estraneo. Non riuscivo a capire, a crederci. Non raccontai a nessuno questa storia, neppure alla mamma. Avevo vergogna. Il tipo non lo rividi più. Non era sicuramente del luogo e non seppi mai cosa realmente stesse cercando dalle nostre parti. La cosa finì lì, ma non dentro di me.
A nove anni ho smesso di andare a scuola. Per frequentare la quarta e la quinta elementare bisognava recarsi in un paese ancora più lontano e la mamma non mi aveva mandato. Non solo per questa ragione. Il primo motivo era perché la scuola era troppo distante da casa; il secondo perché noi, noi contadini e gente di montagna, non vivevamo con i libri, con le parole, ma con il lavoro dei campi; il terzo, perché dovevo iniziare a lavorare e portare soldi a casa e il quarto perché l’analfabetismo, come il dna, faceva parte della nostra cultura.
Lo stesso anno ho incominciato a lavorare portando in un otre acqua da bere ai lavoranti che stavano costruendo una strada di campagna. La mia vita lavorativa era iniziata. Da allora in poi, quando trovavo un lavoro, piegavo le spalle e mi sottomettevo al bisogno.
Un episodio, durante quel mio primo impiego, mi aveva colpito fortemente. Un giorno, quando la strada che stavamo costruendo lo permise, era arrivato in macchina, una Mercedes nera, il padrone. Era di Reggio. Era basso, tarchiato, rubicondo, robusto, tutto vestito di nero. Vicino alla sua auto nera si distingueva solo dal suo viso sanguigno. Il nostro capo corse da lui non appena lo vide. Lo salutò e gli porse la mano, ma il padrone né rispose al suo saluto né gli diede la mano. Invece gli disse qualcosa tra i denti, da incazzato. L’altro non rispose. Rimase lì immobile di fronte a lui umiliato e come un allocco. Il padrone proseguì.
“Perché non mi rispondi, delinquente?”
“Non c’entro per nulla io in questa vicenda”.
“Cosa hai detto?”
“Quello che ho detto.”
Il padrone allora prese a insultarlo. Il capo continuava a stare immobile e in silenzio. Non reagiva. L’uomo basso e vestito di nero, cui non bastavano più le parole offensive – cretino, farabutto, cafone, criminale -, aveva iniziato a picchiarlo dandogli calci e schiaffi. Il capo non mosse un dito, si lasciava picchiare e insultare. Era buffo, ridicolo, da circo, facevano proprio ridere: quel bassotto che picchiava il nostro capo che era, nei suoi confronti, un gigante!
Poi il padrone smise di dargliele. Prima di risalire in macchina aveva fatto il gesto di sganciargli ancora un calcio, ma non lo fece. Entrò nella Mercedes e si chiuse dentro sbattendo la porta. Dopo non poche manovre e accelerazioni per girare l’auto, partì rombando, mentre noi, che non c’eravamo persi nulla di tutta quella scena, riprendemmo a lavorare.
Della “vicenda” di cui aveva parlato il capo, non si è mai saputo nulla. Succedevano tante cose da noi: furti, delitti, stupri, spari, violenza, minacce, arresti, latitanze.
A me, di quell’avvenimento, è rimasta impressa la visione del nostro capo che si lasciava picchiare e ingiuriare da quel palmo d’uomo che lui avrebbe potuto mangiarselo vivo, se solo avesse voluto. Perché non l’aveva fatto?
Si sa che quando si è giovani e inesperti, è facile incorrere in infortuni e, infatti, è stato il mio caso. Ne ho avuti tre e due piuttosto pesanti. Il primo è avvenuto mentre lavoravo in una casa in ristrutturazione. Non so come, ma ho toccato un cavo elettrico e ci sono rimasto appiccicato. Era l’ora di pranzo, gli altri erano andati a casa a mangiare. Io no. Ero solo e, mentre stavo per essere carbonizzato, caso fortunatissimo, è mancata la corrente! Mi hanno trovato per terra mezzo morto. Un’altra volta sono cascato da un’impalcatura, quasi a testa in giù in un impasto di cemento. Ho fatto molta fatica a riprendermi. Il terzo infortunio è avvenuto mentre rompevo pietre calcari con una mazza. Quello che lavorava vicino a me, per sbaglio, ha dato un colpo di mazza sul mignolo della mia mano destra. Fortunatamente ho perso solo l’unghia.
Capitava, non spesso ma capitava, che quando la mamma si recava a Siderno, un paese grande vicino al mare, la sera, andando a letto, trovavo sotto il cuscino qualche caramella. Quella vista, quella carta colorata, frusciante e con il dolce dentro: che delizia!
La mamma era una donna orgogliosa giusta onesta severa con sé stessa e con noi figli. Era una grande lavoratrice. Usava camminare a spalle dritte e a testa alta. Quando portava sul capo l’anfora piena d’acqua, procedeva eretta e con le mani sui fianchi. Era bello vederla camminare così. Aveva un cinto sottile e quell’andatura le donava molto. Della nostra miseria non ne faceva un dramma. Solo qualche volta le sfuggiva qualche maledizione, qualche mugolio soffocato.
Riguardo alle mie sorelle, nonostante fossero gentili, lavoratrici, carine, nonostante ciò, il loro destino era segnato ancora prima di nascere: se fossero state fortunate, si sarebbero sposate, messo al mondo figli e poi si sarebbero dedicate, vita natural durante alla famiglia, diversamente sarebbero rimaste zitelle.
Non è andata così. Sono state due volte fortunate. Prima perché la mamma non le aveva uccise poco dopo la nascita lasciandole fuori di casa al freddo durante la notte e con un panno bagnato addosso, com’era uso fare con le femmine nelle famiglie povere, e poi perché si sono sposate e hanno messo al mondo tanti bei figli.
La barbarie nelle famiglie bisognose di uccidere le figlie alla nascita era dovuta principalmente all’usanza che alle donne, oltre a doverle nutrire fino al matrimonio, si doveva anche dare loro la dote per poterle sposare. La dote, però, per queste famiglie, era praticamente impossibile da procurare. Non c’era lavoro da noi, non c’era niente, solo fame, quindi restavano in casa a carico della famiglia e spesso zitelle a vita. Erano un peso enorme. Meglio ucciderle subito dopo la nascita. Coi maschi era diverso. A loro, oltre ad andare a lavorare sin da ragazzi, non si doveva dare la dote.
Mio fratello Vincenzo l’ho conosciuto pochissimo. Tornato a casa dalla Russia, dov’era rimasto prigioniero per qualche anno dopo la Grande Carneficina, si era sposato e subito dopo era partito per l’America, dove l’aspettava suo padre. Vincenzo era l’unico dei quattro figli a portare legittimamente il cognome degli Sgambelluri.
Non avevo amici, ragazzi con cui giocare eccetto qualche volta un mio cugino. Le mie sorelle non giocavano con me, erano più vecchie e poi non era d’uso giocare tra fratelli e sorelle. Da parte mia, in fondo in fondo, non sentivo il bisogno di mescolarmi con gli altri. Mi divertivo da solo. Non c’era una grande scelta di giochi lì. Da un tronco di quercia mi ero fatto un disco che lanciavo su una stradina solitaria con tutta la mia forza, poi misuravo la distanza raggiunta e col lancio successivo cercavo di superarmi. Un altro passatempo era la fionda. Me l’ero fatta io. Raramente sbagliavo bersaglio quando lanciavo i miei ordigni. Quando non giocavo da solo o andavo a caccia con la fionda, la mia compagnia e i miei amici erano gli animali che accudivo – pecore, capre, maiali, asini, polli. Poi c’erano i miei amati cardellini e, in ultimo, veniva la Timpa (la nostra montagna) che io scalavo e scendevo correndo.
A via di vivere in questo ambiente primitivo e naturale, avevo imparato a imitare il verso di ogni uccello, di ogni insetto e animale, anche del tuono, della pioggia e del vento. Sentivo che la natura mi parlava, le parlavo e m’identificavo con essa.
Mentre pascolavo le capre e le pecore, giocavo coi loro piccoli, correvo cercando di acchiapparli ed ero rincorso dalle loro madri che tentavano di prendermi a cornate e a colpi di testa. Fantasticavo, giacevo supino per terra guardando il cielo per ore, particolarmente quando scalavo la Timpa di corsa e arrivavo in cima ansante. In quei momenti m’immaginavo adulto, libero di viaggiare, di prendere moglie, di fare quello che volevo. Non smettevo di sognare altri luoghi, tipi di vita, popoli, soprattutto dopo aver sentito un paesano parlare della gente del nord.
In casa non c’erano giornali, riviste, libri, nessun tipo di lettura. I libri e i quaderni usati a scuola la mamma li aveva utilizzati per accendere il fuoco. Facevo chilometri a piedi tra sentieri e prati scoscesi per andare da uno storpio a scambiare un mio fumetto che tenevo nascosto per paura che venisse bruciato. Era stato lui, Mimmo, un ragazzo più vecchio di me che avevo incontrato a scuola, a iniziarmi alla lettura dei fumetti. Erano una novità, uno stimolo, un piacere, una rivoluzione culturale vera e propria per la mia giovane mente, i fumetti.
Odiavo i preti. Li odiavo perché mi facevano paura, mi terrorizzavano, mi minacciavano dicendo che se non facevo il bravo ragazzo con Dio e con la mamma, quando fossi morto, sarei andato dritto dritto all’inferno e lì i diavoli mi avrebbero arrostito vivo per l’eternità. Quest’idea m’impauriva non poco e a volte, la notte, non riuscivo neppure a prendere sonno. Erano sempre vestiti di nero, i preti, e il nero era anche il colore delle donne in lutto, soprattutto di quelle che avevano avuto dei morti ammazzati in casa. Venivano i preti, diceva lo zio Carlo, venivano ad annacquare la casa, a spaventarci con le loro storie e a razziare il nostro scarso e sudato cibo, loro che non lavoravano e avevano tutto!
Un episodio che non ho mai dimenticato è stato quello in cui mio cognato, il marito di mia sorella maggiore, Maria, una mattina, senza una ragione e senza un perché, come quel ragazzo sbucato dal nulla che voleva derubarmi, si è tolto il fucile di spalla e ha sparato al mio cardellino preferito. La gabbia era appesa davanti a casa, al solito posto. Pensavo che scherzasse quando l’ho visto togliersi il fucile di spalla e puntare la canna verso l’uccellino. Invece non scherzava affatto. Sparò. Lo uccise. Distrusse anche la gabbia dato che gli aveva sparato da vicino. È stato un vero strazio vedere il mio uccellino passare dalla vita alla morte nel giro di qualche secondo. Quando corsi da lui e lo presi in mano, tremava ancora. Poi più niente. Morto! Ma perché, perché, perché? Cosa gli aveva fatto? Non capivo. Sono rimasto sconvolto, ferito nel cuore, di stucco, pieno di rabbia e di odio per quell’essere. Ho pianto, forte e in silenzio, per giorni. E non solo. In seguito, quest’atto così barbaro e inumano mi ha fatto riflettere non poco sulla brutalità gratuita e spietata degli uomini.
Un giorno, mentre stavo salendo su per una collina, ho incontrato il figlio dello psicopatico che aveva ucciso mio padre, Giuseppe. Non avevamo molta confidenza e si capisce perché, così quando c’incontravamo, ci scambiavamo solo un saluto di cortesia. Lo stesso è stato anche quella volta.
“Ciao.”
“Ciao.”
Camminavamo sullo stesso sentiero separati solo da pochi passi quando fummo colti da un’improvvisa tromba d’aria. In un battere d’occhio ci siamo trovati nel mezzo d’un turbinio di sabbia, foglie, arbusti e rami che schizzavano intorno a noi da ogni parte, alcuni di essi ci colpivano come proiettili. Abbiamo fatto subito dietro front e ci siamo messi a correre a rotta di collo verso casa. Giuseppe, che era dietro di me, mi ha superato. Correvamo, correvamo e correvamo per mettere in salvo la nostra vita. Lui, ahimè, non ha corso per molto. Eravamo a metà collina quando un ramo spezzato l’ha colpito tra testa e collo. È caduto a terra e io gli sono quasi arrivato addosso.
“Su, andiamo,” dissi.
Non rispose. Lo scossi. Niente. Dalla testa usciva sangue. Era svenuto, morto, non sapevo. Provai a trascinarlo, ma non per molto. Era pesante, impossibile continuare a farlo. Le raffiche di vento poi erano troppo forti e non davano tregua. Allora lo lasciai lì sul terreno e corsi, corsi con tutta la mia forza in cerca di aiuto sfidando quelle furie scatenate che, d’un momento all’altro, non temetti più.
Giuseppe, quando lo ritrovammo più tardi dopo l’uragano, era ancora vivo. Non morì, rimase solo zoppo.
* Preso, i 12 post di cui è composta questa mia breve autobiografia, dal terzo libro della Trilogia. “Figlio degli elementi e del big bang, l’autobiografia cosmica d’un essere umano”.

❤️