La mia vita, secondo post *
Il salto
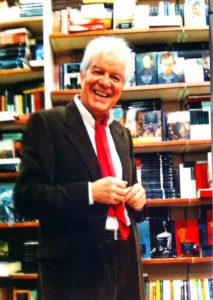 Compiuti i sedici anni, confuso e smarrito fra tante idee, desideri e incomprensioni, ma deciso e contro la volontà della mamma, me ne sono andato, andato via da casa, lasciando la famiglia, le bestie, la mia Timpa, i miei sogni da bambino e il luogo dov’ero nato e vissuto la mia prima giovinezza, e sono partito per il nord Italia.
Compiuti i sedici anni, confuso e smarrito fra tante idee, desideri e incomprensioni, ma deciso e contro la volontà della mamma, me ne sono andato, andato via da casa, lasciando la famiglia, le bestie, la mia Timpa, i miei sogni da bambino e il luogo dov’ero nato e vissuto la mia prima giovinezza, e sono partito per il nord Italia.
A Torino ho dormito in garage freddi, bui, scalcinati, con la neve sul tetto e l’acqua che gocciolava dentro. Mi è capitato anche di abitare in case e locali disastrati dove non c’era un gabinetto, non c’era acqua potabile, non c’era igiene, non c’era niente, solo un lurido materasso per terra sul quale si dormiva vestiti insieme ad altri.
Il lavoro l’avevo trovato quasi subito. Non mi piaceva lavorare in fabbrica, preferivo, anche perché quell’impiego non mi era completamente estraneo, lavorare in cantieri edili e, in questo campo, il lavoro si trovava facilmente. Il mio primo impiego l’ho ottenuto da un pazzo ma simpatico piccolo imprenditore romano che aveva preso in appalto la costruzione d’una villa in montagna. Ci portava lì, me e altri 3 disgraziati, ogni lunedì mattina in una camionetta della volkswagen che guidava in quelle strade piene di curve e pericolose a tutto gas. Ci terrorizzava. Veniva poi a riprenderci il sabato sera. Il capo mastro era del luogo.
Quando avevo guadagnato un po’ di soldi, ho lasciato il sudiciume in cui ero finito al mio arrivo a Torino e ho affittato una camera in corso Francia. La signora che me l’aveva affittata con colazione e cena era molto gentile. Teneva tutto nitido in casa, e poi lenzuola pulite, camera riscaldata e si mangiava a tavola con forchetta, cucchiaio, coltello e tovagliolo! Questo cambiamento è stato un vero e proprio passare dalle stalle alle stelle.
Le prime lettere che ho scritto alla mamma, non sono stato io a scriverle, ma la signora che mi affittava la camera. Non mi piaceva questa cosa, ma non avevo scelta, non sapevo scrivere. M’immaginavo la mamma che, a sua volta, anche lei doveva andare dal prete per farsi leggere le mie lettere e farsi scrivere quelle che poi avrebbe spedito a me. Questo traffico, anni dopo, mentre leggevo un libro sulla Grande Carneficina, mi ricordava molti di quei ragazzi del sud che erano andati a farsi ammazzare nello sfacelo di Caporetto e che neppure loro sapevano scrivere o leggere e, come me, anche le loro lettere dovevano farsele scrivere e leggere dagli altri.
Torino, verso la fine degli anni Cinquanta, non si riduceva solo al mio lavoro con quel simpatico ma pazzo imprenditore romano e alla mia nuova e confortevole sistemazione in corso Francia. C’era dell’altro. Oltre a essere una città fredda, nevosa e grigia, particolarmente d’inverno, c’era anche la fatica e la durezza della vita. Nonostante ciò, a me Torino piaceva molto, mi apriva gli occhi e svegliava in me il sapore per un mondo che non conoscevo, un mondo che era ancora tutto da scoprire.
Il contrasto poi tra Nord e Sud, almeno per quello che ne capivo io, era shoccante, umiliante, drammatico. Com’era possibile tanta differenza? Si era pur sempre in Italia! Eppure la realtà era questa. I due posti, il nord e il sud, erano così diversi l’un dall’altro da fare rabbrividire anche il più avveduto degli antropologi.
Non parlavo italiano quando sono arrivato a Torino, parlavo il dialetto. Però, e questo mi ha molto sorpreso, riuscivo a imparare in fretta l’italiano. Con chiunque parlavo, in quei giorni, per me era sempre una lezione di lingua. Ce la mettevo tutta a imitare l’accento e a cercare di capire il senso delle parole.
Il mio primo amore per una ragazza emiliana è finito dolorosamente. Lei era una semi-analfabeta, io ero un semi-analfabeta, per non dire che eravamo due analfabeti. Quale futuro per noi e per i nostri figli? E comunque io ero ormai determinato, volevo andare a scuola, studiare. Ero pronto a iniziare di nuovo dalla prima elementare. Non avevo mai dimenticato il trauma di quando la mamma non mi aveva più mandato a scuola. Ora l’idea di poterla riprendere si era impossessata di me, era diventata la mia guida, la mia ambizione, la mia luce. Non so come dirlo, ma intuivo che non volevo vivere e morire da analfabeta. Tutto, ma non un analfabeta. Così, il mio primo amore è stato sacrificato per questo ideale.
La passione, quando viene stroncata barbaramente e senza una ragione plausibile, e io non l’avevo questa ragione, fa male, molto male. Sentivo che ero dalla parte del torto. Quale colpa lei? E, d’altro canto, quale chance io? Insieme, poi, quale futuro per noi e per i nostri figli? Anna, e lo sentivo, era una ragazza meravigliosa, piena di amore e d’entusiasmo per la vita. È stata un’esperienza dolorosa, una strage di sentimenti forti e innocenti. Il primo lutto del cuore. Niente, è andata così ed è andata malissimo. Questa esperienza potente e straziante ha lasciato in me un senso di colpa e di ribellione che ancora oggi, a volte, tormenta il mio sonno.
Sotto le armi, per tutti quelli che non avevano conseguito la quinta elementare, era obbligatorio andare a scuola. Io ero uno di questi. Non potevo sottrarmi. Non volevo neppure. Anche questa è stata un’esperienza dura e dolorosa. Sentivo lo scherno di alcuni commilitoni ferire il mio orgoglio e vedevo sui loro volti la commiserazione che provavano per uno della mia età che doveva andare ancora alle elementari!
Mentre imparavo italiano e altre materie nella scuola dell’esercito, per conto mio cercavo d’imparare il francese con l’aiuto d’un dizionario bilingue (il Ghiotti, ce l’ho ancora) e leggevo quanto potevo con l’aiuto, questa volta, d’un piccolo vocabolario italiano. Pian piano, quando non ero impegnato in manovre ed esercizi militari, leggevo tutto quello che trovavo in giro: fumetti, libri, giornali, riviste e copiavo interi brani con l’unico scopo d’imparare a scrivere. Ero diventato in brevissimo tempo ingordo di letture, racconti, vicende umane, in breve, ingordo d’apprendere.
Sotto la naia ho imparato subito la cosa giusta da fare: rispettare le regole. Lo facevo, e lo facevo per convenienza, pur detestando il servizio militare e quel tipo di cultura bigotta e nazionalistica.
Erano trascorse solo due settimane da quando ero arrivato al campo di Caserta, quando venne a cercarmi, mentre ero in mensa, il sergente per portarmi da un capitano.
“Da un capitano, e perché cosa?” chiesi.
“Non fare domande e seguimi,” rispose.
Il capitano, quando il sergente mi lasciò nel suo ufficio, disse: “Siediti!” Così ho fatto. Lo guardai. Mai visto prima.
“Sono tuo zio,” disse.
“Mio zio?”
“Sì, sono il fratello di tuo padre, quello che è stato ucciso nel campo da quel folle. Tu e le tue sorelle, in realtà, siete dei Ferreri e non degli Sgambelluri, portate solo il suo cognome. Il vostro sangue è quello dei Ferreri,” e mi raccontò una storia che ignoravo totalmente.
Il mio vero padre, continuò, era andato da giovane in Canada in cerca di fortuna. Lì aveva avuto un incidente sul lavoro, si era infortunato a una gamba. Qualche tempo dopo era ritornato in Italia. In Calabria, in un mercato del bestiame di Siderno, aveva visto la mamma. Colpo di fulmine. Si era innamorato ciecamente. Si era informato su di lei. Seppe che il marito era in America, seppe che aveva un figlio, seppe che era figlia degli Schirripa. Niente, fece di tutto per averla e infine ci era riuscito. Subito dopo questa unione romantica, aveva, con l’aiuto di alcune persone della zona, fatto in modo che se il legittimo marito fosse ritornato per reclamare sua moglie, venisse riempito di piombo. Questo non avvenne mai, e lui ebbe il tempo di mettere tre figli al mondo e di godersi la sua amata fino a quando non fu ucciso.
Alla fine di quell’inaspettato incontro con questo zio capitano spuntato dal nulla, e dopo avermi raccontato ancora tante altre cose della famiglia (pare che qualcuno dei Ferreri sia stato sindaco di Bologna e questo me l’aveva confermato anche una mia sorella molti anni dopo) di mio padre e della proprietà che i Ferreri avevano a Siderno Superiore, mi diede una licenza d’una settimana, cosa che mandò in bestia tanti miei commilitoni, perché ero appena arrivato al campo e avevo ottenuto subito una licenza!
Riguardo alla vera provenienza dei Ferreri, ancora oggi non so esattamente se erano di Bologna o erano calabresi che si erano trasferiti a Bologna. Avevo cercato, anni dopo l’incontro con lo zio con le stellette, di fare alcune ricerche sul Web, ma non sono riuscito a trovare nulla di preciso.
Al ritorno da quella licenza, non rividi lo zio capitano e non seppi più nulla della sua esistenza. Ho pensato che lui, forse, aveva visto il mio nome su qualche lista ed era venuto lì apposta per conoscermi. In ogni modo, quell’uomo, quell’incontro sono stati per me un vero e proprio fulmine a ciel sereno.
Era trascorso un mese da quand’ero ritornato dalla licenza e non avevo ancora fatto una sola guardia, non avevo lavato una sola volta i calderoni con acqua fredda e fuori nel cortile, piovesse o meno, non avevo spazzato la cucina, i dormitori o i cessi. E non solo. Non avevo neppure preso una punizione e questo non perché avevo uno zio capitano nell’esercito, ma perché, per mia volontà, mi attenevo alle regole e se mi capitava di non rispettarle, lo facevo in modo che nessuno si accorgesse. Questi lavori li facevano tutti quelli che venivano puniti. A me andava benissimo, così io potevo dedicare il mio tempo a cose a me più care.
Però, quel mio modo di fare, non a tutti, evidentemente, andava bene come andava bene a me. Una domenica a pranzo, un commilitone dalla faccia butterata e dall’aspetto cattivo, chiamò il sergente di turno e gli disse ad alta voce e chiaro e tondo che quel giorno le marmitte avrei dovuto lavarle io, perché, da quand’ero arrivato, non avevo mai fatto una guardia o lavato i piatti, i cessi, i dormitori. Io, sentendo questo, non ci vidi più, qualcosa mi era calato sugli occhi. Istintivamente presi dal tavolo una bottiglia di vino non ancora aperta e gliela ruppi in testa con tutta la mia forza. Cascò a terra. Non si moveva. Portarono subito lui in infermeria e me in cella.
L’ho saputo dopo da un camerata che non l’avevo ammazzato, fortunatamente per lui e per me. Quando si fu rimesso e io uscito di cella, si era accontentato di aspettarmi dietro la porta del refettorio e vigliaccamente, mentre uscivo, mi diede un pugno allo stomaco e poi corse via. La cosa, tra me e quel tipo, finì lì.
Il maestro dell’esercito, poco prima di finire il servizio militare, mi consegnò la pagella della quinta elementare dicendo: “Almeno con questa potrai fare lo spazzino!” Questa frase, detta così, fu per me come una stilettata al cuore. Non l’ho mai dimenticata.
** Preso, i 12 post di cui è composta questa mia breve autobiografia, dal terzo libro della Trilogia. “Figlio degli elementi e del big bang, l’autobiografia cosmica d’un essere umano”.
